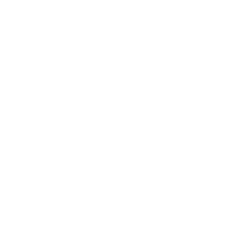"La terra trema, cadono le case vuote e quelle piene. Si è costretti ad allontanarsi dal paese, si perde una comunità che in qualche caso si era già affievolita e ci si ritrova in comunità provvisorie. In albergo, nelle tende, nei containers, nei villaggi prefabbricati ci sono tanti disagi, ma ci sono anche nuove compagnie, fatte di intimità e distanza, di terremotati e soccorritori. Insomma, la tragedia può sempre contenere qualche filo di luce.
Quando nella mia terra finì il boato e il tremore, mi accorsi che il paese non era caduto: andai verso la piazza, c’eravamo tutti, c’era la chiesa, c’era il castello. Eppure ebbi il sospetto di un qualcosa di grande che mi avrebbe cambiato la vita".
Franco Arminio, scrittore, poeta e fondatore della Casa della paesologia, animatore in rete del blog Comunità provvisorie, ha raccontato sulle pagine di Repubblica dello scorso 5 novembre, il terremoto di questi mesi attraverso il ricordo del terremoto che nel 1980 colpì l'Irpinia e di quello che successe negli anni successivi. "Un terremoto grande in realtà non finisce mai. Non è una ferita che si apre e poi subito si richiude, è una storia nuova che cambia tutto. C’è un prima e un dopo terremoto, come c’è un prima e un dopo Cristo".
Il terremoto infinito
"La terra trema, cadono le case vuote e quelle piene. Si è costretti ad allontanarsi dal paese, si perde una comunità che in qualche caso si era già affievolita e ci si ritrova in comunità provvisorie. In albergo, nelle tende, nei containers, nei villaggi prefabbricati ci sono tanti disagi, ma ci sono anche nuove compagnie, fatte di intimità e distanza, di terremotati e soccorritori. Insomma, la tragedia può sempre contenere qualche filo di luce.
Quando nella mia terra finì il boato e il tremore, mi accorsi che il paese non era caduto: andai verso la piazza, c’eravamo tutti, c’era la chiesa, c’era il castello. Eppure ebbi il sospetto di un qualcosa di grande che mi avrebbe cambiato la vita.
In piazza c’era molta animazione. Verso le dieci di sera si cominciò a sentire che nei paesi vicini era un disastro. Andai con alcuni amici a Sant’Angelo dei Lombardi. Quello fu l’inizio di un viaggio nel terremoto che forse non è mai finito. A Sant’Angelo la grande luna di quella notte illuminava una ventina di ragazzi stesi e impolverati sul marciapiede davanti al bar Corrado. Non solo non c’era più il bar Corrado, ma anche tutte le palazzine che venivano dopo. Era la parte moderna del paese, quella che quando arrivavi dai paesi vicini sembrava dirti: noi qui abbiamo il progresso, sembriamo una piccola città. Niente crepe in quelle palazzine, niente squarci o crolli parziali, tutto schiacciato verso terra, come se una mano avesse premuto ciecamente dall’alto. A Sant’Angelo per 482 persone, sindaco compreso, non ci fu la pena della ricostruzione e quella della prima emergenza. In una casa vecchia ti puoi ritrovare con una trave di legno sulle gambe, puoi trovarti in una casa che è diventata una piccola capanna e magari qualcuno ti viene a tirare fuori. I palazzi di cemento armato quando cadono non lasciano scampo.
Alla fine ci furono quasi tremila morti e molte conseguenze anche nel campo della politica: forse la Lega non sarebbe nata senza il grande stimolo degli scandali, veri e presunti. Il capo dell’opposizione annunciò una svolta nella politica del suo partito. Il Presidente della Repubblica gridò contro i ritardi dei soccorsi. Storie note, storie facili da raccontare.
Il terremoto dell’Appennino meridionale segnò uno dei primi e forse anche l’ultimo momento di grande vicinanza tra il Nord e il Sud del paese. La ricostruzione fu orientata secondo la spinta centrifuga che era già in atto: ognuno ebbe la possibilità di farsi la casa dove voleva. Si può dire che allo sfollamento dei paesi subito dopo la scossa, seguì lo sfollamento dei centri antichi. Si immaginò che il terremoto fosse l’occasione per coniugare ricostruzione e sviluppo e invece ci fu solo una lentissima ricostruzione, che in qualche caso non è ancora terminata.
Un terremoto grande in realtà non finisce mai. Non è una ferita che si apre e poi subito si richiude, è una storia nuova che cambia tutto. C’è un prima e un dopo terremoto, come c’è un prima e un dopo Cristo.
In Irpinia il dopo fu l’inverno che arrivò assai presto e ogni volta che veniva un altro inverno la vita dei terremotati era sempre più difficile: dalle tende si passò nei containers o nelle case di legno. Poi si pensò alla ricostruzione: gli Irpini ebbero la casa, ma persero i paesi.
In certi paesi c’era più vita nei mesi successivi al terremoto di quanta ce n’è adesso. Trentasei anni dopo dei morti sarà rimasto poco, dei vivi ancora meno. Trentasei anni dopo gli Irpini non hanno ancora elaborato il loro lutto. A un certo punto essere terremotati era diventata quasi un’identità, una condizione che sembrava esserci stata da sempre e che doveva permanere per sempre. Ma tutto finisce, e quasi ti stupisci che si ferma il valzer delle betoniere, la rincorsa al contributo. I soccorritori vanno via, i paesi diventamo musei delle case chiuse. E allora torna quasi la nostalgia di quei giorni in cui i saluti avevano una grana più dolce, come se la sventura comune avesse di colpo spezzato quei rivoli di maldicenze e malumori che trovano la massima esaltazione nella figura dello scoraggiatore militante: eroe del fallimento, luminare della bancarotta antropologica in cui stiamo vivendo.
A me, nei giorni che seguirono il terremoto, piaceva tutta quella gente per strada, tutti che si guardavano come se ognuno fosse una cosa preziosa. Ricordo che una sera quando ancora si dormiva nelle macchine mi sono fatto un giro, li ho benedetti uno per uno.
Franco Arminio
da La Repubblica del 5-11-2016